CAPITOLO 5
Pagliara Dei Marsi






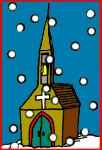
 ra cambiano
argomento e passiamo ad occuparci di Pagliara dei Marsi paese d’origine di mia madre , nome che richiama i luoghi dolci dell’infanzia e
della giovinezza, meritevole senza
dubbio di una consistente sezione
d’approfondimento.
ra cambiano
argomento e passiamo ad occuparci di Pagliara dei Marsi paese d’origine di mia madre , nome che richiama i luoghi dolci dell’infanzia e
della giovinezza, meritevole senza
dubbio di una consistente sezione
d’approfondimento.
Lo ricordo da sempre, nel
bauletto dove custodisco le vestigia del passato - una luccicante scatola delle
caramelle "Sperlari" - conservo ancora la cartolina indirizzata “al piccolo Marco Tiddi, Pagliara dei Marsi
L’Aquila” che zia Maria mi scrisse nel giugno 1957, la mia nascita come
ormai ben sapete risaliva all’aprile di quell’ anno, avevo quindi circa due mesi quando, con il mio bagaglio
di pannolini , bavaglini e biberon , percorsi per la prima volta la sinuosa via
della Madonna per approdare presso le
amate sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque.
Siamo in pieno Boom , come tanti altri paesi del centro
e del meridione anche questo paesello di montagna si è svuotato rapidamente, i
più giovani vengono a cercare fortuna nei ministeri e nelle amministrazioni
della capitale , i vecchi rimasti
osservano con raccapriccio i campi inaridire e i raccolti marcire.
Nel periodo estivo il sabato sera televisivo è
territorio esclusivo di Marisa Del Frate e Raffaele Pisu , dalle
finestre e dalle porte socchiuse delle
cucine al piano terra delle case di
Pagliara saettano i bagliori dei pochi televisori presenti in paese ,
trasmettono la trasmissione L’Amico del Giaguaro, nell’aria ,
insieme alle risate e alle canzoni del varietà , si diffonde il penetrante
odore dei camini accesi.
Pagliara significava prima
di tutto libertà, a Roma non potevo ancora uscire da solo, tutt’al più mi
permettevano di scendere al negozio di vini e oli sotto casa o dal panettiere
di fronte , in paese al contrario potevo muovermi liberamente, al sicuro dai
pericoli della città, che mamma, rimasta
probabilmente scioccata da quel che m’era accaduto un giorno al ritorno
da scuola , identificava principalmente nel fiume di automobili che
attraversava incessantemente la zona .
Era l’ora di pranzo , mi trovavo, cartella sulle spalle, scarpe
slacciate e fiocco penzoloni, di fronte
casa, al semaforo tra piazza Gondar e viale Etiopia ,e come al solito ero
incautamente sceso dal marciapiede in attesa che si facesse vivo l’omino dell’Avanti -
evidentemente un socialista
- per consentirmi di attraversare
la strada . Improvvisamente
un’utilitaria , nel passarmi accanto,
con la maniglia della portiera agganciò la manica della mia giacca e mi
trascinò per qualche metro sull’asfalto. Niente di grave, non ci rimisi che una
vecchia giubba usata, eredità di mio fratello, e qualche pezzo di pelle di ginocchio , ma che paura!
In verità a Pagliara rischi
ce n’erano, eccome , la montagna da
scalare , gli alti muretti situati nei caratteristici viottoli del paese dai
quali ciondolare, le immense grotte piene di pipistrelli, crepacci e stalattiti , da esplorare con i
compagni di gioco . Soprattutto queste erano labirinti nei quali era difficile
orientarsi e la cui unica via d’uscita era rischiarata da un piccolo falò acceso poco prima da un
nugolo di ragazzacci impazienti di penetrare nelle viscere della terra, il
tutto era ovviamente riccamente insaporito dall’incoscienza dell’età.
Indelebile resterà nella
memoria lo spavento e il grave pericolo corso un pomeriggio di un milione
d’anni fa quando , arrampicatomi imprudentemente su un alto dirupo al di sopra
delle grotte di Beatrice Cenci , restai
aggrappato per oltre due ore ad un
costone di roccia sospeso ad oltre venti metri dal suolo, non riuscendo a trovare
un appiglio per scendere o continuare a salire e raggiungere così la provinciale.
Solo nostro Signore mi salvò la pelle prendendomi per il colletto e
aiutandomi a raggiungere un ramo sporgente oltre il quale un invisibile
sentiero, nascosto da un folto cespuglio ,conduceva in basso. Un’esperienza da panico!
Chissà perché tutto questo
faceva meno paura?
In paese tutti si conoscevano , se non si era parenti
si era perlomeno compari. Le macchine non potevano entrare in paese, chi
tentava l’ardua impresa di percorrere la stretta viuzza principale che saliva
verso la Costarella slittando su quelle
pietre lisce e scivolose il più delle
volte ci rimetteva le fiancate dell’adorata Fiat 600.
Quando s’avvicinavano le
sospirate vacanze estive e il caldo si faceva insopportabile non volevo nemmeno
sentir parlare di mare, paletta e
secchiello – ero già rimasto scottato
da un simile habitat , e che ustioni!
- per me esisteva soltanto quell’incantevole
paesino incastonato tra i monti della Marsica.
Mentre mamma preparava lo
spuntino e il termos pieno d’acqua necessari al lungo viaggio, papà sudava nel laborioso tentativo di ammassare
nell’angusto bagagliaio valigie, pentole e tegami ansimando e brontolando sotto
il sole rovente che picchiava implacabile su Piazza Gondar.
Il cammino era lungo e
faticoso, stipati nel sedile posteriore di una scintillante Fiat 1100 bianca
con tettuccio verde quattro piccoli diavoli scatenati contavano le curve che li
separavano da “Pagliarà sur la mère”,come
la chiamava papà riferendosi, non certo al mare di cui ovviamente non
c'era traccia , ma ai nauseabondi gomitoli di escrementi, prodotti dai bovini
del luogo, di cui era particolarmente ricca quella terra d’Abruzzo. Oggi è
assai più difficile trovarne.
La prima parte del tragitto
fino a Tivoli scorreva abbastanza tranquilla, si cantava a squarciagola il repertorio
anni sessanta oppure si passava il tempo con il gioco delle targhe che consisteva nello scovare tra quelle delle
automobili in transito quella più vecchia.
All’allegria della partenza
subentravano tuttavia, man mano che il lunotto posteriore ingoiava l’asfalto, la stanchezza e la noia
,
e, puntuale ed inesorabile , cominciava allora la lagna.
Trascorsa la prima ora si
lasciava la Tiburtina e incominciava l’interminabile scalata ai Colli di Monte
Bove ,un calvario di curve , buche e dossi che mettevano duramente alla prova i
pneumatici consumati dal pietrisco di quella via polverosa e lo stomaco dei
malcapitati passeggeri.
Dai finestrini la strada
bianca ,non ancora asfaltata ,si snocciolava lenta e soporifera sotto i nostri
occhi rasentando il monte ,la monotonia
si spezzava quando un’auto, proveniente in senso contrario, si affiancava alla
nostra,in quel caso spesso papà era
costretto a rallentare o addirittura a
fermarsi quando la larghezza della carreggiata non consentiva il contemporaneo transito
nei due sensi.
Incrociare la corriera lungo
il percorso era una vera sciagura, superare su quelle strade sconsigliabile ,
non restava che accodarsi ed in breve un lungo serpentone di auto s’
incolonnava lungo i tornanti impaziente di superare l’ostacolo non appena
possibile.
Uno dopo l’altro tutti e
quattro lasciavamo un po’ di noi stessi , non intendo in senso figurato, ai
piedi della montagna.
Anche per il conducente la
stanchezza cominciava a farsi sentire , mamma tentava di tenerlo sveglio parlandogli,
memore della preghiera di Nino Manfredi ai suoi compagni di viaggio ne
“L’audace colpo dei soliti ignoti”,” Dateme
chiacchiera sinno’ m’addormo!”
Nei sedili posteriori intanto c’era chi si lamentava per la sete, chi accusava mal di pancia e chi, più fortunato, era riuscito ad appisolarsi cullato dal tranquillo rollio dell’automobile.
A tarda sera finalmente,
nella fitta oscurità s’intravedeva un fioco bagliore che ad intermittenza
andava e veniva oltre le numerose curve che si susseguivano chilometro dopo
chilometro,era la luce del villino della maestra alla periferia del paese.
La nausea e lo sfinimento svanivano come per incanto e tornava l’eccitazione della partenza.
La “materna genesi che lo stral d’Artemide trafisse”,come la chiamava
il marito, ci faceva infilare i golfini , l’aria s’era fatta più fresca, felici
contavamo una ad una le ultime curve che ci separavano dall’agognata meta
finché quel chiarore , finalmente immobile, segnalava il lungo rettilineo
finale che conduceva a Fonti Nova. La fida “1100” superava la fontana , il
villino di zio Italino e la villa di Lucrezia. Sbirciando il buio al di sopra
delle siepi alla nostra sinistra potevamo scorgere le pallide luci del paese ,
pochi metri ancora e compariva il bivio, sotto la strada s’udiva, appena
percettibile, lo scorrere dell’acqua di Fonti Canala in un silenzio rotto soltanto dall’ incessante
canto dei grilli.
Era ormai buio quando la
macchina affrontava , sfinita , l’ultimo nastro di strada bianca che dal
bivio si srotolava lento formando una
specie di braccio che , all’altezza della retta, piegava il proprio gomito fino a rasentare il piccolo camposanto per poi spingersi fino
alle prime case del paese.
L’ esausto conducente con un
ultimo sforzo parcheggiava alla via della
Madonna la brava utilitaria che con un sordo brontolio s’addormentava
stremata ma compiaciuta.
Tutti a terra!
Sfregavamo le mani per il freddo fattosi pungente cercando di stappare le orecchie otturate dall’altitudine, quindi iniziavamo a trasportare pacchi, valigie e borse a piedi fino a casa .
Paolo e Piero ,afferrate le
sacche più pesanti, ci precedevano.
Prima di accingermi alla
sfacchinata mi voltavo indietro e ,nel vedere la via del braccio avvolta nella più completa oscurità, valutavo,
terrorizzato, l’agghiacciante
eventualità di rimanere lì da solo, la paura dava un insospettabile vigore a
quelle mie gambette storte che prendevano ad inerpicarsi con buona lena lungo
la stradina fino a raggiungere quelle di papà cui m’ accostavo rassicurato
consapevole di quel che m’aspettava poco più avanti.
Abbandonata infatti, dopo
una ventina di metri la via principale, ribattezzata oggi via Marsicana, si
scendeva a sinistra in una viuzza laterale inghiottita dalle tenebre che
passava accanto alle macerie di un vecchio rudere,covo di streghe e orchi nella
fantasia dei bambini, proseguiva a ridosso della chiesa parrocchiale, tra
sterco di vacca, erbacce e sassi ,e sbucava infine nella piazza S. Salvatore
accanto al monumento ai caduti, era la via
della chiesa, meglio nota ai bimbi del paese come la terrificante via dei morti.
Percorso l’ultimo tratto con
gli occhi sbarrati ,nel timore di perdere di vista papà , proseguivo
costeggiando il campanile e scendevo finalmente sulla piazza di fronte alla chiesa dove riposava tra le gli altri Santi , deposto in una teca di vetro alla destra
dell’altare, nostro Signore.
Ero letteralmente terrorizzato da quella sinistra
scultura posta al di sotto della Madonna della neve che ritraeva il
corpo ignudo del Messia . Durante le funzioni domenicali lo sguardo era
rotolato spesso in quel sarcofago ed io
rabbrividivo anche solo a pensare a
quell’orrenda visione, le membra erano scarne , il torace insanguinato ed il volto pallido ed emaciato. Quel povero
Cristo, naso sottile, palpebre
calate e labbra socchiuse aveva l’aspetto di un autentico cadavere per chi non
ne aveva ancora mai visto uno dal vivo
– spero perdonerete la battuta - per
fortuna a quell’ora il pesante portale della casa di Domineddio era ormai chiuso
, l’ora del vespro era passata da un
pezzo.
La nostra villetta
affacciava, e affaccia tuttora, proprio sulla piazza così, mentre papà si affannava a cercare furiosamente tra le altre la chiave del
cancello, io, felice dello scampato pericolo, curiosavo tra le finestre
illuminate delle case per controllare che tutti i miei amici fossero già in
paese. Finalmente la chiave giusta saltava fuori, un rapido saluto a zia Linda
e zio Pompilio che abitavano lì accanto, poi di corsa giù per le ripide
scalette che conducevano verso il portone di casa.
Qualche minuto dopo ci
raggiungevano mamma ed Aurora che avevano terminato la consueta via Crucis di saluti e baci a parenti e amici che
villeggiavano nelle case lungo il percorso.
I fratelli più grandi depositati i fagotti sparivano in cerca degli amici, per me invece quella prima giornata era già finita prima di cominciare, il viaggio era stato faticoso ,restava solo il tempo per aiutare mamma a disfare le valigie e per un rapido saluto a zia Maria, poi tutti a nanna.
Per fortuna , riflettevo nel
mio letto, ci sarebbe stato il giorno dopo, il sole avrebbe fatto un lungo giro
attorno ai monti che cingevano il paese prima di lasciare ancora una volta il
posto al buio della notte.
L’indomani arrivava
puntuale, non era più il suono dei clacson che assediava Piazza Gondar a
svegliarmi, ma il cinguettio degli
uccelli che facevano toletta sul noce che protendeva i suoi rami fino a
sporgersi sulla veranda . Il mattino ammiccava, dapprima qualche timido raggio
di sole tra le imposte socchiuse,poi pian piano i dardi dorati s’intrufolavano
curiosi nella stanza disegnando sulla parete misteriose figure che mi sforzavo
d’interpretare.
Mamma s’era alzata
presto e poco dopo rientrava in camera
con il latte caldo.
Era ora d’alzarsi!
Una rinfrancante pisciatina
facendo bene attenzione a sistemarlo tra una sbarra e l’altra del parapetto per
non bagnare la veranda e farla scorrere direttamente nel prato sottostante - il
bagno esterno c’era ma vuoi mettere il gusto di fare pipì all’ aperto! - una
veloce colazione,un lavaggio piuttosto approssimativo a denti e viso, il tempo
strettamente necessario per infilare mutande, calzoncini corti e maglietta ed
ero pronto per uscire.
L’aria era frizzantina, il
cielo terso ,cominciava la pacchia!
Al di là del cancello, in
cima alla scala ,m’aspettava il paese delle meraviglie.
Lungo la via incontravo uno
ad uno gli amici e insieme andavamo a svegliare i più pigri rimasti ancora a
letto..
Quanti eravamo!
Sandro, Sergio,Gianni
d’Ottorina,Tonino,Maurizio, Remo ,Paolo del Marinaro,Paoletto di Memena, Nino,
Paoletto di Licia, Massimino, Bruno, Gianni di Giustino, Luciano, Fabrizio e forse qualche altro che ora non ricordo,
un’allegra brigata di svitati con una gran voglia di far danni e divertirsi.
Prima tappa d’obbligo,la
bottega di zio Adolfo!
Con aria burbera c’impediva
d’avvicinarci, troppo piccoli per giocare a carte,diceva lui,in realtà era
terrorizzato alla sola idea di quel che avremmo potuto combinare ai tralci di
vite che pencolavano dal pergolato che dava ombra alla veranda del suo emporio.
Armati di fionda e cerbottana eravamo infatti un’orda di barbari in cerca di
prede da cacciare, lucertole, nidi di uccelli o semplici grappoli d’uva. Non ci
restava che invertire la marcia e dirigere le truppe verso l’altro spaccio del
paese ,quello di Nannina, la presenza
con noi del figlio Sergio favoriva il nostro accesso al campo di bocce
o alla saletta riservata al gioco delle carte.
Briscola , tresette a
quarantuno ed eventuale bella ancora a tresette ma stavolta a cinquantuno, in
palio per la coppia vincente il più delle volte una misera gassosa, prezzo
politico quaranta lire,il sabato sera,al ritorno in paese di gran parte dei
papà da Roma per il fine settimana,nelle nostre tasche approdava la paghetta e
il premio per i vincitori si faceva più interessante: una fresca e dissetante
aranciata dal costo esorbitante di sessanta lire.
Di tanto in tanto si andava tutti insieme sotto un sole rovente a dar la caccia a lucertole, serpi e altre povere bestiole , domiciliate per loro sfortuna sul vicino monte Girifalco o nei dintorni di Pianezze. In qualche caso, in mancanza di prede, finivamo per prenderci di mira tra di noi con spiacevoli conseguenze per i più sfortunati centrati da pietre micidiali lanciate da fionde sempre più evolute.
Sulla montagna, nei pressi della diramazione dove la mulattiera prosegue verso la Cona o scende in direzione del bottino dell’acqua, avevamo costruito con pietrisco, grossi massi e cemento a presa rapida una sorta di fortino dove ci trinceravamo in attesa dell’arrivo degli immaginari briganti provenienti dalla vecchia torre in rovina che si ergeva di fronte l’Arcigalante.
Più a valle tra la fitta vegetazione al di sotto della via della Madonna, all’altezza del cimitero,avevamo edificato una capanna decisamente più rifinita. Dopo aver interrato grossi rami nodosi nel terriccio umido del sottobosco accanto ai Pianili – un terreno erboso appena al di sotto della strada - li avevamo legati insieme con arbusti verdi e pruni spinosi lasciando una piccola feritoia protetta da una porticina di rami intrecciati per consentire l’ingresso , avevamo poi innalzato una sorta di tetto con ramoscelli verdi, paglia e foglie secche e infine piastrellato l’interno con delle mattonelle, sottratte proprio in casa mia, maioliche che si erano rese necessarie per una delle tante ristrutturazioni di “villetta Fernandella” .
Non sempre uscivo con i
compagni,spesso preferivo restarmene nello spiazzo di fronte casa a giocare per
conto mio,disponevo buona parte del mio esercito di soldatini - quelli
minuscoli dell’Atlantic – sulle
piastrelle del terrazzino, gli altri ,
nascosti nel parapetto di mattoni che separava la veranda dal piazzale, erano
pronti a tendere l’imboscata . Dopo averli distribuiti meticolosamente lungo
l’intero perimetro della loggia davo inizio alla crudele carneficina. Tedeschi,
inglesi, americani e giapponesi, non meno di duecento combattenti con tanto di
pistole, fucili e mitragliatrici, s’affrontavano in eroiche battaglie che
difficilmente terminavano con un vincitore .
Quando papà decideva di scendere al villino della maestra per andare a trovare zio Italino mi univo volentieri a lui , scendevamo insieme lungo la via delle Scalette fino a Fonti Nova .
Mentre il baldo genitore conversava amabilmente con il vecchio amico che, ormai quasi completamente cieco, impiegava il tempo rimastogli ad impagliare sedie, io e Lucietta,la nipote che veniva in villeggiatura da Guardiagrele, dopo aver gustato la crostata ancora fumante preparata da zia Rosina, correvamo a giocare in giardino.
Arrivava l’ora del pranzo e quando papà veniva a cercarmi per rientrare in paese, il più delle volte mi trovava sdraiato all’ombra degli alberi ad assaporare serenamente insieme alla mia compagna di giochi le mele appetitose dell’orto attiguo al villino.
Non dimenticherò mai le simpatiche gote vermiglie di quella ragazzina, le treccine more che incorniciavano quel grazioso visetto e i suoi occhioni scuri, né potrò scordare la spensieratezza e l’allegria di quelle ore trascorse insieme.
Solo qualche estate insieme poi scomparve, era cresciuta , la vacanza in montagna dalla zia, evidentemente, non le bastava più.
Circa quattordici anni più tardi , inattesa , la sorte volle che le nostre strade tornassero ad incontrarsi, un traffico epistolare che durò un paio d’anni scaturito dal fortuito incontro con la sorella Maria Grazia che ne prese il posto al villino, con la quale pure imbastii una sincera amicizia e tenni, al ritorno dalle vacanze, un nutrito scambio di lettere per qualche tempo.
All’epoca le chat non esistevano , se volevi scambiare quattro chiacchiere con qualcuno dovevi prendere carta e penna, recarti dal tabaccaio o presso l’ufficio postale e spedire la missiva con tanto di francobollo attendendo pazientemente che il postino la recapitasse per poi aspettare che l’eventuale risposta percorresse il cammino inverso. Il tempo reale della posta elettronica era ancora lontano ma l’attesa stuzzicava la fantasia e stimolava l’ingegno rendendo molto meno virtuali e superficiali certe amicizie.
Stiamo parlando tuttavia di avvenimenti di là da venire,ingraniamo la retromarcia e torniamo a quel tempo fatato.
Prima del pranzo mamma riempiva una grande tinozza d’acqua perché provvedessimo ad un sommario bagno che potesse renderci perlomeno riconoscibili dopo una mattinata trascorsa a rotolare nell’erba dei campi attorno al paese o a giocare a nascondino in piazza.
Era più o meno quella l’ora in cui sopraggiungeva Maria d’Aldo con la conca traboccante dell’acqua gelata di Fonti vecchia in precario equilibrio sulla testa. l’acqua corrente all’epoca era ancora una chimera nelle case dei pagliaresi e per dissetarsi occorreva ricorrere alle varie fonti e polle d’acqua che sgorgavano nei dintorni del paese.
Bere direttamente dalla conca con il grande mestolo di rame dava tutto un altro gusto a quell’ acqua fresca che in parte colava lungo il mento non trovando il giusto approdo alle labbra, un passo indietro per non farla gocciolare sulla maglietta,un respiro profondo per riprender fiato,poi ancora un lungo sorso per togliere la sete dopo una partita a pallone sotto un sole cocente o una dura scarpinata sui monti. A quel punto arrivava l’ora di depredare il vecchio e rumoroso frigorifero Zoppas anni 60 con lungo maniglione d’alluminio che, utilizzato anche in piena notte , faceva tanto incazzare il povero papà svegliato all’improvviso dal frastuono della chiusura a scatto.
A quegli anni leggendari risale il primo sfuggente incontro con la morte avvenuto proprio a Pagliara.
L’ora di cena era passata da un pezzo , ero un discolo di sette , otto anni, forse meno, gironzolavo intorno alle granulose mura di casa De Rubeis , dimora estiva di zia Maria , controllato a vista da papà , domandandomi come mai mi permettessero di restare a zonzo fino a un ’ora tanto insolita . Dalla casetta accanto si udiva un brusio indistinto che interrompeva a tratti il canto dei grilli , nell’aria ancora il profumo della cena , l’atmosfera era irreale, ogni tanto l’uscio si socchiudeva e attraverso la fessura e il cono di luce che il lampadario della cucina proiettava sul selciato entrava o usciva qualche muso lungo . Abiti scuri, sguardi afflitti, lucciconi agli occhi, la situazione m’incuriosiva. Che diavolo era successo?
Fu proprio tendendo l'orecchio ai commenti dei passanti riuniti negli improvvisati capannelli di fronte a quella casa che compresi quanto stava accadendo : qualcuno là dentro era passato a miglior vita . Così, sfuggito temporaneamente all’arcigna sorveglianza paterna , m’accostai all’uscio rimasto accostato e sbirciai all’interno , l’odore di candele era fortissimo , nell’ampia cucina una coppia di vecchie megere preparava il caffè per gli ospiti , una terza befana , accanto al caminetto acceso, sgranava un rosario a testa china farfugliando frasi senza senso, forse una preghiera.
Entrai , la grande cucina era affollata ma nessuno pareva badare a me, m’avvicinai alla soglia della stanza attigua e guardai dentro, era lì, immobile , disteso sopra un antico – o forse solo vecchio - letto in ferro battuto con indosso l’abito blu delle feste , accanto a lui nella semioscurità della camera funeraria guizzavano le fiammelle dei ceri accesi che ne illuminavano i contorni in un angosciante gioco d’ombre e chiaroscuri. Bianco come un cencio il volto appariva emaciato, il naso affilato ed un fazzoletto gli fasciava il capo per finire annodato sotto il mento . Rabbrividii, cercai di allontanare il mio sguardo da quella povera salma , un vero salmone considerate le dimensioni – Totò, sono certo, saprà perdonarmi se continuo a rubargli lazzi e battute, ma come si fa a non pescarne a piene mani in quel caleidoscopio di comicità che sono i suoi film . Poi qualcuno mi scorse, mi prese per mano e m’accompagnò finalmente fuori dove m’aspettava mia madre che dopo aver rassettato la cucina aveva raggiunto mio padre.
I parenti più stretti vegliarono il defunto tutta la notte , un autentico veglione – ancora lui – noi tre ce ne tornammo invece a casa, quella notte , come capirete bene, non riuscii a chiudere occhio.
Ma ora mettiamo da parte i tristi ricordi e accomodiamoci intorno alla tavola apparecchiata per il pranzo.
Gli orari in casa Tiddi , almeno in un primo tempo , erano tassativi , a pranzo e cena ci si sedeva tutti contemporaneamente, l’ appetito non mancava mai e l’aria di montagna l’aumentava , con la spiacevole conseguenza per il povero papà di doversi sottoporre ad ore ed ore di straordinario per riuscire a sfamare l’insaziabile prole.
Piatti di pastasciutta, melanzane alla parmigiana e gustose polpette sepolte da una valanga di croccanti patatine fritte sparivano fagocitate dalla voracità di quattro cavallette fameliche. Mamma, nauseata dall’odore del parmigiano , allontanava la formaggiera e spiluccava la frutta ,papà tentava improbabili diete lette sulle riviste estive e, tormentato dai morsi della fame, annusava l’odore di soffritto fissando inebetito la patata lessa con contorno di fagiolini sconditi adagiata malinconicamente nel suo piatto.
Disgraziatamente dopo il “frugale” pasto arrivava l’ora più detestata, quella del riposino pomeridiano.
Ahimè ! Paolo e Piero filavano subito via in cerca degli amici,i gemelli invece restavano confinati in casa ,costretti ad un forzato sonnellino in attesa che il sole a picco si decidesse a dare corpo alle ombre.
Come animali in gabbia ce ne restavamo appollaiati nei nostri giacigli in attesa che la corriera delle 15,30, la mitica Forletta-Porsinelli, raggiungesse Fonti nova e , suonando il clacson, segnalasse l’ora della nostra liberazione.
L’agognato suono echeggiava ancora nella valle ma noi eravamo già sgattaiolati via oltre il cancello inseguiti dalle raccomandazioni di mamma e papà. Il pomeriggio era appena iniziato c’era tempo perché venisse a dargli il cambio l’ombra della sera. Il manipolo di discoli in un batter d’occhio si riuniva di nuovo, pronto a nuovi spassi.
Poco oltre la cabina della luce ,in via della Madonna, alle falde del monte c’è un ampio blocco di roccia brulla e levigata , è lì che convogliavamo quando si decideva di andare a fare lo scivolo, una vera strage di pantaloni, quelli corti che si indossavano in quegli anni,in un solo giorno ne massacrai tre paia . Mamma , con infinita pazienza, tentava ogni volta di ricucirli salvando il salvabile ma il compito era laborioso e l’esito incerto, d’altronde anche calzini,magliette e pullover, annientati da arbusti, sterpi e rami spinosi non avevano vita facile.
Un giorno accadde l’inevitabile.
Correvo ,come al solito, a perdifiato dietro un pallone ,all'improvviso inciampai in una radice che spuntava dal terreno e stramazzai rovinosamente, per tutta la mia allora scarsa lunghezza, dentro un nauseabondo mucchio di letame di vacca.
Sì! Proprio così! Ero finito nella merda.
Altre volte mi capiterà in futuro ma mai in senso tanto letterale.
Non sto qui a descrivervi la faccia di mia madre quando mi vide tornare a casa coperto di cacca,la guardai negli occhi poi, con la tipica espressione da cane bastonato, tentai di sdrammatizzare l’ imbarazzante situazione:
“Le scarpe però non me le sono sporcate.” Sottolineai.
Una puntualizzazione importante in fondo, considerato lo scempio di calzature di cui ero capace all’epoca.
Non di rado c’incamminavamo verso i paesi limitrofi percorrendo decine di chilometri solo per andare a comprare il gelato a Petrella o per assistere alla festa patronale a Corcumello, non era certo l’energia che ci mancava. Il momento più atteso era tuttavia quello della partita di calcio contro la squadra di calcio dei Castellicchi.
Castellafiume è un comune che dista da Pagliara, che ne è una frazione, circa tre chilometri e, come spesso accadeva a quei tempi - grazie a Dio l'Europa unita era ancora lontana , né avevamo ancora tra i coglioni Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi - tra gli abitanti dei due paesi non correva buon sangue .
Non era raro il caso quindi che si finisse per venire alle mani. Vincere quindi la consueta partita di mezz’agosto diventava una questione d’ onore e le tifoserie non erano meno passionali dei calciatori in campo.
Sul podere di Nannina o su quello accanto di Edda ,nei pressi del bivio,con un clima torrido o sotto un cielo carico di nuvolosi grigi, non aveva importanza, cominciava palpitante la sfida.
La difesa a tre formata dall’atletico Marco Tiddi dal granitico Sandro Paolucci ,coppia di terzini insormontabile,e dallo scattante Fabrizio Carletti, attente sentinelle alla porta difesa dal sicuro Remo Di Marzio, era supportata qualche metro più avanti ,dall’agile Paoletto Milia a copertura del centrocampo composto dallo sgusciante Gianni Di Marzio,dal vigoroso Massimino Ombres e dal guizzante Paolo Di Marzio, preziosi suggeritori per i micidiali attaccanti ,il rapido Tonino Meco e il poderoso Sergio Lustri. In panchina, sempre pronti ad entrare in campo , il veloce Paoletto D’Innocenzi , l’ imponente Bruno Di Marzio e l’opportunista Maurizio Di Marzio.
Sì lo so! Giocavamo in nove, ma il rettangolo di gioco, non consentiva la contemporanea presenza in campo di ventidue giocatori.
Vincere era imperativo.
Su quel campetto a conca , sassi e radici sporgenti mettevano a dura prova l’equilibrio dei giocatori muniti di scarpe da ginnastica consumate in punta o di semplici mocassini sfondati. Si inseguiva il pallone di cuoio senza applicare evolute tattiche di gioco,correndo in discesa verso il cerchio di centrocampo, tratteggiato qualche ora prima con la calce, per poi risalire verso la porta avversaria per infilare l’incolpevole portiere avversario.
Le porte erano delimitate da due maglie piuttosto vistose appoggiate sul terreno a guisa di pali, immobilizzate da un paio di grossi sassi, rimpiazzate, in caso di gara di particolare interesse ,da lunghi bastoni interrati sormontati da una corda tesa per delineare un’ approssimativa traversa.
Spesso procurarsi nove maglie dello stesso colore era problematico, di conseguenza non era agevole riconoscere i propri compagni di squadra durante le convulse fasi di gioco, unica soluzione possibile quella che uno dei due schieramenti scegliesse il completo “Torso nudo”,collezione “Arrangiatevi” del noto stilista “Nature”, per distinguersi dall’altro che indossava maglietta o canottiera.
L’incontro aveva una durata indeterminata ,spesso terminava a sera inoltrata per lo sfinimento di una delle due formazioni con risultati astronomici del tipo 14 a 10.
Dal bordo del prato,anch’esso piuttosto indefinito,salivano alte le grida d’incitamento delle ragazze e quelle d’ ammirazione dei nostri fratelli e genitori che assistevano alla partita, motivo d’orgoglio per tutti noi che davamo l’anima in campo.
Di tanto in tanto si andava poi a giocare in trasferta a Castellafiume con l’intero seguito dei supporter.
Percorrevamo entusiasti i tre chilometri che ci separavano dal campo avversario,si trattava infatti di disputare un match vero su un terreno di gioco pianeggiante demarcato da linee laterali, d’ area e di centrocampo, cercando di segnare in una porta reale provvista di pali e di traversa.
Vincere fuori casa era esaltante ,l’incoraggiamento dei nostri sostenitori pungolava il nostro entusiasmo fornendo insospettabili energie a quelle nostre ossute leve che sgambettavano spedite verso l’area avversaria alla ricerca spasmodica del goal che poteva darci la vittoria e la definitiva apoteosi.
Un pomeriggio ci recammo a giocare su un magnifico campo d’erba, a Petrella Liri , un paesino nei dintorni, il risultato era fermo sull’insolito punteggio di due a due, improvvisamente, a seguito di una corta respinta della difesa avversaria , il pallone s’impennò scendendo a campanile verso di me che mi ero eccezionalmente spinto in avanti ,mi coordinai ed appena fu alla giusta altezza riuscì ad effettuare una splendida rovesciata calciando con forza di collo pieno, il pallone s’infilò sibilando nel sette ,alle spalle del pur bravo estremo difensore della squadra avversaria scatenando l’entusiasmo dei tifosi.
Chi se la scorda più quella rete! Gonfio d’orgoglio ,con la gioia che sprizzava da tutti i pori me ne restai con i miei occhialetti sulla punta del naso, legati con l’elastico dietro la nuca , a raccogliere l’applauso degli adulti e non m’accorsi nemmeno che la partita nel frattempo era già ricominciata. Pochi minuti dopo l’incontro terminò con il risultato di 3 a 2 , il nostro rientro in paese fu trionfale.
Se in programma non c’era niente di particolarmente interessante da fare non ci si perdeva d’animo,con buona lena ci arrampicavamo sul monte Girifalco per scalare la torre , visitare le caverne sull’Arcigalante o raggiungere semplicemente la Cona per giocare a “Tre, tre, giù, giù”.
Il panorama che si gode da lassù è sbalorditivo,spalle alla nicchia della Madonna ridotta ormai ad un cumulo di macerie, eretta lassù in tempi lontani , lo sguardo coglie, voltandosi ad ovest, il verde intenso di un manto erboso che tra cespugli e rovi spinosi sale verso la vetta dell’Arcigalante spesso avvolta tra le nuvole montate a panna.
Ad est le rovine della torre si stagliano minacciose contro il cielo azzurro mentre verso sud scendono piccoli sentieri appena visibili e rozze mulattiere lastricate di pietre taglienti.
Tornando sui propri passi verso la stradina che riconduce in paese si scorge l’incantevole ricamo dei pascoli erbosi di Pianezze .
Volgendo lo sguardo verso il basso, serpeggia la strada del braccio, un tempo bianca ,a metà sonnecchia il camposanto e in fondo, paciosa, se ne sta sdraiata Pagliara con i suoi tetti rossi ,la chiesa , il campanile e un grappolo di case raccolte in uno stretto abbraccio per darsi coraggio l’un l’altra.
La minaccia è la Pietra Incatenata , un gigantesco masso che con la sua mole imponente se ne sta aggrappato alla montagna come una spaventosa spada di Damocle , la roccia è comunque tenuta a bada da una povera croce lignea - la crocetta appunto - posta dagli abitanti a salvaguardia dell’incolumità del villaggio.
Indirizzando lo sguardo a nord infine, si domina la vasta piana del Fucino, dove in una baraonda di colori, spiccano tra squarci d’ombra e di luce mucchietti di case spruzzate qua e là, intervallati da campi di grano e prati verdi intersecati da stradine di campagna che raggiungono piccoli villaggi, case isolate e paesi operosi accovacciati tra le colline, da dove, lontano ma distinto, s’ode persino il vocio dei paesani.
Le montagne in fondo sembrano accennate con leggerezza come in un acquerello da una mano rapida e nervosa e all’orizzonte s’intravede, quando il cielo è terso, il profilo del Monte Velino che s’erge maestoso come lo spettacolare fondale di un’opera teatrale.
Accennavo poco prima ai nostri ,non proprio idilliaci, rapporti di vicinato con i castellicchi, spesso quelli che cominciavano come banali litigi per i più futili motivi finivano per trasformarsi in feroci zuffe.
Tutti noi a parte Sergio, Tonino e Gianni,non eravamo che gracili ragazzini di città in trasferta a Pagliara, francamente troppo mingherlini per affrontare i ragazzotti locali di Castellafiume fortificati dal lavoro dei campi e corroborati da una sana vita all’aria aperta.
Ovviamente quando volavano gli sganassoni le prendevamo di santa ragione e non era raro il caso che a sera qualcuno di noi tornasse a casa con un occhio nero, non era comunque nostra abitudine porgere l’altra guancia e incassare vagonate di sberle senza batter ciglio.
Arrivammo perfino a metter su una specie di palestra in una stalla nei pressi della nuova scuola , prendendo vigorosamente a pugni grossi sacchi di sabbia appesi alle travi cercavamo di irrobustire le braccia e indurire le nocche delle mani per poter render pan per focaccia ai villici d’oltre bivio.
All’insufficiente prestanza fisica sopperivamo comunque con l’astuzia.
Un giorno, al ritorno da un’escursione sulla Cona, scorgemmo accanto al bottino dell’acqua, al di sopra al cimitero nel punto dove il monte si divide in due versanti , uno pietroso l’altro più ricco di vegetazione, un gruppo di puledri incustoditi al pascolo .
Li avevamo già notati nei pressi del cimitero di Castellafiume quei cavalli, condotti da alcuni ragazzini con cui avevamo avuto uno dei soliti diverbi.
Come si permettevano quei bifolchi!? Portare i loro animali a pascolare sulle nostre terre?
L’incoscienza dei ragazzi prese il sopravvento,la decisione fu unanime, afferrate le redini li portammo via,conducendoli fino alla via del Braccio . Per fortuna a quel punto un barlume di giudizio ci fece rinsavire e li abbandonammo legati all’albero della “Retta”, un grosso albero,che oggi non c’è più, situato in un angolo di prato accanto alla strada dove il “braccio” piega il “gomito”, ombroso ristoro per chi, stanco, si ferma un attimo a riposare prima di riprendere il cammino e dove, nelle buie e tiepide notti estive, nacquero per tanti di noi ,acerbi e cocenti, i primi amori.
Comunque il luogo preferito da tutti noi, dove trascorrere spensierati gli assolati pomeriggi estivi, era il fiume.
Raggiunta, attraverso la via delle Scalette o quella dei Vignavi ,la statale che dopo una lunga teoria di curve e brevi rettilinei raggiunge Petrella Liri, la lasciavamo dove oggi è collocato il secondo bivio - allora non esisteva - che porta in paese entrando dalla parte opposta alla via della Madonna. Scavalcato il muretto di recinzione della strada ci addentravamo nella vasta distesa erbosa che si estende fino a raggiungere all’orizzonte le pendici dei monti di Pianezze.
Dopo un paio d’ore di faticoso cammino raggiungevamo la meta, un sinuoso fiumiciattolo che serpeggia tra l’erba alta e ad ogni ansa raccoglie le sue acque in stagni limpidi che ,risucchiati dal fondo melmoso, si lasciano andare a qualche rapida piroetta prima di tuffarsi in spumeggianti cascatelle .
Senza indossare costumi che d’altra parte nessuno di noi possedeva ci immergevamo nell’acqua gelata di quel torrente annaspando come cagnolini cercando con la punta dei piedi il fondo lastricato dai ciottoli levigati .
Un pomeriggio sguazzavamo allegramente completamente nudi in quelle acque chiare assieme ad un gran numero di pesci e girini quando si presentarono, ospiti inattese, le ragazzine della comitiva che, sdraiatesi tranquillamente lungo le sponde ,cominciarono a conversare tra di loro impedendoci di uscire da quel fiume gelido.
Infine, paghe della burla, si decisero, quando già l’ombra della sera era scesa sulle rive, a lasciarci in pace e , imboccato il sentiero appena tracciato nell’erba, s’avviarono lungo la via per far ritorno in paese.
Emergemmo finalmente da quelle acque glaciali simili a bastoncini Findus e chi pagò il prezzo più alto di quello scherzo fu Nino che si beccò una mezza polmonite terminando anzitempo la sua vacanza .
Quante ne combinavamo!
A sera ,quando i nostri fratelli più grandi andavano a ballare al riparo da occhi indiscreti sulla veranda della vecchia scuola ,c’armavamo di palloncini ,opportunamente riempiti d’acqua alla fontanella collocata all’inizio del paese,e cominciavamo un fitto lancio all’indirizzo delle coppie lascivamente avvinghiate che si lasciavano andare ai peccaminosi lenti di quel periodo. Subito dopo ce la davamo a gambe sparpagliandoci in tutte le direzioni inseguiti dai maschi del branco che, quando riuscivano a pizzicarci , non esitavano a metterci la testa sotto il getto della fontanella per insegnarci a non rompere più i coglioni.
Una notte ci introducemmo di nascosto, dopo aver scavalcato furtivi il cancello del cortile, nel villino della maestra e le sottraemmo tutti i vasi di fiori mettendoli a mollo nel lavatoio di Fonti Nova,non soddisfatti tornammo in paese e sostituimmo una ad una tutte le tendine parasole alle porte delle case che affacciavano sulla via principale partendo da via della Madonna fino a raggiungere Pagliaterra.
Protette dalle tenebre delle ore notturne le nostre scorribande si facevano ancora più audaci. Una notte , schierati in fila indiana lungo il viale di fronte alla bottega di zio Adolfo, con i calzoni calati fino alle ginocchia, mollammo con il minimo sforzo le nostre pestilenziali creature, scoperte, con evidente ribrezzo , dai primi passanti alle prime luci dell’alba il giorno dopo.
Ancor più grossa la combinammo quando in piena notte entrammo di soppiatto in chiesa , sgusciammo in sacrestia ed acceso il vecchio giradischi utilizzato da Don Ezio per richiamare i fedeli al vespro serale o alla funzione domenicale ,sostituimmo sul piatto il soporifero disco dell’Ave Maria con quello di Whola Lotta Love dei Led Zeppelin. Il silenzio della notte fu improvvisamente squarciato dal ritmo incalzante di Robert Plant e soci che svegliò l’intero paese mentre una dozzina di folletti dispettosi si dileguavamo in gran fretta protetti dall’oscurità della notte.
A settembre la mia famiglia rientrava in città ma io rimanevo in paese ospite di zia Marcella , delle sue dorate patatine fritte e delle sue deliziose minestrine, fino all’inizio del nuovo anno scolastico che all’epoca non cominciava mai prima del mese di ottobre.
Dormivo in camera con mio cugino Maurizio, ma le notti allora non erano fatte per dormire,il tempo rimasto prima del ritorno a Roma dovevamo utilizzarlo per colossali sbornie e divertenti scorrerie notturne.
Fu lui a farmi conoscere le avvincenti storie, ambientate nel periodo della guerra d’indipendenza americana contro le spietate giubbe rosse, del Comandante Mark, intrepido ed invincibile trapper delle grandi foreste del nord America , dei suoi lupi dell’Ontario e dei divertenti compagni d’avventura Mister Bluff e Gufo Triste . Scovai i suoi albi a fumetti nella cassapanca accanto al camino della cucina tra la legna da ardere e i vecchi giocattoli andati in pensione , non tardai ad innamorarmi di quel personaggio tutto d’un pezzo, di quei suggestivi paesaggi nordici e di quell’atmosfera crepuscolare. Per qualche estate misi così da parte Tex, Carson e Tiger Jack, poi , preso dal rimorso e dalla nostalgia tornai pentito a Canossa.
Al ritorno dalle nostre ragazzate anche le poche ore che restavano prima dello spuntar del giorno le impiegavamo per parlare dei nostri tormenti d’amore,la passione per l’altra metà del cielo cominciava infatti a far breccia nei nostri giovani e inesperti cuori.
Ognuno di noi era più o meno segretamente innamorato , il guaio più grosso consisteva nel fatto che, essendoci in giro ben poca fauna di sesso femminile rispetto alla gran quantità di maschi in calore,si era tutti più o meno in caccia della stessa selvaggina.
Come era già accaduto ai nostri fratelli maggiori era arrivato anche per noi il tempo dello squilibrio ormonale e dei balli notturni guancia a guancia in piazza S. Salvatore ,al campo di bocce di Nannina o in qualche confortevole prato in fondo al paese.
Sotto un cielo trapuntato da miliardi di stelle gli ammiccamenti di ragazzine esuberanti pronte a strofinarsi con voluttà premendo quelle poppe che parevano scoppiare contro i nostri corpi inermi stimolavano, con la connivenza silenziosa di una Luna impicciona, licenziose voglie troppo a lungo sopite.
Qualche anno dopo ci si inizierà a nascondere nelle stalle al riparo da occhi indiscreti e le cose cominceranno fatalmente a complicarsi ma per ora l’amore , quello con la “a” maiuscola,è ancora lontano nel tempo, vuoi mettere al suo confronto una piacevole passatella o un’incursione notturna nei campi per farsi una gustosa cotta di patate alla faccia di quel povero contadino che ha faticato tutta una stagione per strappare qualche frutto al suo arido podere!
Nel periodo compreso tra gli ultimi giorni d’agosto e la fine di settembre le nostre bravate raggiungevano il culmine, la maggior parte dei romani se ne tornava in città e il paese restava alla mercé dei superstiti della banda, i più pericolosi , quelli fermamente intenzionati a saccheggiare frigoriferi e dispense. . Senza più freni inibitori forzavamo la serratura delle abitazioni ormai disabitate soltanto per il gusto di farci un caffè, tracannare bibite,vini e liquori lasciati sconsideratamente nelle cantine o per farci una spaghettata con il necessario scovato nella credenza delle cucine .
Quando il sole tramontava al di là dei monti e s’avvicinava l’ora di cena non era il caso d’allontanarsi,nei cortili e nei portici di fronte alle case si sentiva quel tipico profumo di cucina che fa venire l’acquolina in bocca. I papà cominciavano ad affettare il pane e le mamme mettevano l’acqua sul fuoco per la pasta,c’era solo il tempo per fare un salto nella fucina di zio Aristide, l’Archimede Pitagorico del paese, falegname fabbro, idraulico e via dicendo. Qualsiasi cosa vi venga in mente lui la sapeva fare.
Uno spettacolo vederlo lavorare tra le mura della sua officina tra limature,trucioli di legno, pennelli,viti, chiodi di tutte le misure e strani arnesi che solo lui sapeva far funzionare.
Sulle pareti grezze erano attaccati grandi poster a colori delle locandine di vecchi film western anni cinquanta e l’interno era impregnato di un particolare odore di colla e vernici, tutto era perfettamente in ordine ed anche il più insignificante pezzetto di legno , il più piccolo avanzo di nastro adesivo era conservato con cura in un’ arrugginita scatola di latta di biscotti, poteva tornar utile più in là per qualche nuovo lavoretto.
Il vecchio zio Aristide, magro come un chiodo, naso adunco e barba bianca ,mal rasata e ispida , era muto ma riusciva a comunicare con tutti noi grazie a quel misterioso aggeggio nascosto dietro l’orecchio che amplificava la sua voce dandole un singolare timbro metallico.
Era l’anima della festa che si teneva in paese a metà agosto in onore del patrono del paese, Sant’Antonio, dalle sue abili mani sottili e scarne prendevano forma ogni anno i fondali per gli spettacoli serali, le decorazioni, gli ornamenti e i festoni che garrivano al vento sospesi tra una casa e l’altra ma soprattutto Gemma, l’inquietante pupazzona di legno e cartapesta , animata dalle gambe in giù dal vigore dei giovanotti, che ballava in piazza al ritmo insistente delle marcette suonate dalla banda.
Quel fantoccio era un simulacro di gioia e trepidazione per tutti i ragazzini del paese che le correvano incontro eccitati per poi darsela a gambe levate quando, piroettando, si faceva troppo vicina, passata la paura tornavano a farsi sotto lanciando gridolini per darsi coraggio e scappavano di nuovo al suo minaccioso riavvicinarsi.
Quella danza rituale si ripeteva ad intervalli regolari per tutta la durata della festa poi , l’ultima sera , prima dei fuochi artificiali che annunciavano la fine dei festeggiamenti , mentre i bambini stremati si facevano asciugare il sudore dalle mamme , nel silenzio generale si accendeva un gran falò. Gemma bruciava lentamente , il suo scheletro di legno crepitava sinistro , la cartapesta avvampava , fino a quando quel che ne rimaneva precipitava in fiamme oltre il parapetto della piazza per rischiarare l’orto del prete.
Era sempre quello strampalato ed eclettico Geppetto che organizzava i giochi dei bambini, la corsa dei sacchi, la gara della pignatta, quella della pastasciutta o l’albero della cuccagna.
Già , l’albero della cuccagna….quel grasso spalmato per rendere più ardua la scalata sull’alto palo interrato perpendicolarmente di fronte alla bottega di Nannina non riuscì a fermarmi, ci voleva ben altro per ostacolare la sicura arrampicata di un esemplare metà ragazzino metà scimmia come me . Quell’anno , eravamo agli sgoccioli del decennio, arrivai in cima per primo e riuscii ad afferrare un magnifico fortino di legno , anche quello opera sua.
Purtroppo il fantastico modellino di Forte Apache fece una brutta fine , ero appena rientrato a Roma dopo le vacanze quando le quattro sottili palizzate di legno separate da altrettante torrette che ospitavano le giacche blu, malgrado la strenua difesa di quegli eroici combattenti , bruciarono sul parquet della mia stanza . Quel devastante incendio era stato appiccato da una coraggiosa banda di indiani ribelli fuggiti dalla riserva che, ancora una volta , erano riusciti a cacciare fuori dai loro territori l’invasore bianco.
Anche la prova della pastasciutta era, è proprio il caso di dirlo, pane per i miei denti . Un vero specialista!
Mani legate dietro la schiena curvata in avanti e occhialetti allacciati come al solito dietro la nuca con un elastico per non farli scivolare dal naso nella foga della sfida, al via inabissavo la faccia nella scodella spazzando via in pochi minuti quel fumante intreccio di spaghetti. Terminata l’immersione , con il muso e il colletto della maglietta insudiciati dal buon sugo di lepre cucinato da zia Rosina , giravo la testa verso destra e verso sinistra per una rapida occhiata ai piatti degli avversari ancora pieni a metà poi , petto in fuori, mi concedevo al gagliardo applauso della folla che assisteva alla competizione assiepata intorno al monumento ai caduti di fronte al quale era stata imbandita con lunghe assi di legno la tavola.
Scendeva infine la sera, nell’aria si diffondeva l’intenso odore dei camini accesi e il freddo si faceva pungente , il cielo era gonfio di pioggia e il brontolio dei tuoni , che rimbalzava da una cima all’altra dei monti intorno al paese , annunciava l’ imminente temporale.
Un lampo folgorava la Cona,ancora un cupo fragore di rombi,lo stormire delle fronde degli alberi poi il cielo si faceva più scuro e cominciava a tirare secchiate d’acqua sulle case che previdenti avevano serrato le imposte.
Una folgore rantolava più vicina , la pioggia veniva giù sempre più fitta ed io mi godevo lo spettacolo al riparo sotto l’arco della scuola, batteva insistente sui tetti poi scivolava lungo le grondaie riversandosi nei catini e nei barili . Dopo averli colmati traboccava sul terreno impregnato e prendeva a serpeggiare tra i sassi bianchi e viscidi portando con sé terriccio e ciottoli,infine si raccoglieva nell’ incavo ai piedi della stele dedicata ai martiri della guerra e con un ultimo sussulto spariva ingoiata dal tombino di fronte alla piazza sotto la croce di ferro. Nelle stalle gli animali cullati dal picchiettio della pioggia sulle travi di legno s’addormentavano esausti.
Dal mio confortevole rifugio udivo forte le grida e lo schiamazzo dei vecchi che fumando e bestemmiando giocavano a briscola nella bottega di zio Adolfo discutendo animosamente per il lancio di un carico mai richiesto o di una briscola sprecata.
Chi s’era attardato,ingannato da un sole incerto,a passeggiare sulla via della Madonna tornava precipitosamente in paese con la giacchetta sulla testa per ripararsi dalla pioggia sempre più battente.
Le ombre sparivano completamente,l’odore d’erba bagnata si faceva più intenso ,il martellio del temporale più incessante e si scatenava il finimondo poi,come per incanto,la pioggia prendeva a scemare e tornava a far capolino un timido sole.
La gente tornava in strada e solo il petulante ticchettio delle gocce d’acqua che dalle grondaie cadevano nelle botti e nelle tinozze attorno agli edifici ricordava loro l’acquazzone che ormai, balbettando gli ultimi mugugni d’agonia ,s’allontanava verso Pianezze offuscato da una densa coltre di nebbia che copriva le cime più alte.
Ancora il tempo per una sfida a bocce, una partita a carte o una camminata lungo la via del braccio fino al muretto per ammirare il sempre sbalorditivo spettacolo dell’arcobaleno che solcava il cielo sopra la torre, poi di nuovo a casa .
Ma adesso facciamo un passo indietro di qualche anno , quando anche a Pagliara non uscivo ancora di casa senza essere accompagnato dai miei genitori.
Il venerdì pomeriggio sapevo che ci avrebbe raggiunto papà per il fine settimana ed insieme ad Aurora ,quando era prossima l’ora del suo arrivo uscivo sulla veranda dalla porta finestra della camera e mi sporgevo dalla ringhiera verde per tenere d'occhio la strada bianca che baluginava lontana trafitta dai raggi del sole.
Ero più che consapevole che la mia percezione visiva avrebbe dato risultati piuttosto deludenti perciò tendevo l’orecchio a sventola attento al suono del clacson , sapevo che papà l’avrebbe suonato una volta raggiunto il bivio. Puntuale la tromba dell’auto annunciava il suo arrivo e con lui del Corriere dei Piccoli o del giocattolo che ero certo mi avrebbe portato.
Seguivo a fatica il puntino che percorreva la via del braccio fino a scomparire oltre la curva a gomito della retta per poi ricomparire oltre il camposanto e i miei occhi stanchi , nascosti dietro quele spesse lenti, l’accompagnavano sospingendolo quasi fino all’ingresso del paese, poi correvo verso il cancello per attendere l’ apparizione del papone nazionale in carne, ossa e valigetta ventiquattrore, sicuro che quella sera, prima di addormentarmi ,mi avrebbe letto una bella fiaba.
Sì, aspettavo emozionato quel suono di clacson come quello della Forletta -Porsinelli o quello della banda la mattina della festa.
Già la festa.
Al mattino ,ancora sdraiato nel mio letto, captavo lontane le note del Piave intonate dalla banda, la musica pian piano s’avvicinava facendosi più forte, saltavo giù dal letto appena in tempo per accoccolarmi tra le gonne di mamma prima che il primo sparo annunciasse l’inizio dei festeggiamenti.
Lo sparatore - Carlino mi pare si chiamasse - appostato nel campo dei Vignavi proprio sotto il nostro villino, dopo aver acceso le micce scappava via verso il riparo più vicino e un attimo dopo una fiammata saliva in alto annunciata da un sibilo prolungato . Il cuore mi balzava in gola , poi , atteso ma non per questo meno temuto, il fuoco esplodeva violentissimo macchiando il cielo azzurro con una nuvoletta di fumo bianco . Le pareti di casa vacillavano, il boato rintronava rimbalzando come una palla da monte a monte fino a spegnersi nell’ultima eco. Impaurito abbracciavo le gambe di mamma accostandomi sempre di più , sapevo infatti che quello non era che il primo dei tre botti che di lì a poco avrebbero turbato la tranquillità della vallata.
La piccola nube biancastra dell’ultimo sparo ancora si sfilacciava nel cielo terso quando il silenzio appena ristabilito veniva nuovamente rotto dal ritmo incalzante delle campane che suonavano a festa, la folla che s’era avvicinata al muretto della Piazza per assistere ai fuochi, si raccoglieva davanti al portone della chiesa,all’ombra del campanile, commentando ad alta voce, per superare il suono delle campane ,l’ esibizione di Carlino, prima di entrare in chiesa per la celebrazione della Messa.
I bambini eccitati correvano sulla piazza inutilmente esortati alla calma dalle mamme ansiose che temevano per il vestitino nuovo acquistato pochi giorni prima, e dal paziente parroco del Paese, Don Ezio Del Grosso , sempre in pena per i pesanti candelieri e i pregiati arredi sacri.
Anch’io come il resto dei ragazzini il giorno della festa ero costretto a vestirmi come un manichino della Upim e a sottopormi a scrupolose abluzioni a orecchie,ginocchia e piedi, ad un meticoloso taglio delle unghie e ad un minuzioso lavaggio ai capelli - solitamente trascurati - prima di poter varcare la soglia del cancello che conduceva in piazza.
Non ero affatto contento, mi sentivo prigioniero di pantaloncini troppo aderenti che m’impedivano di fare lo scivolo lungo la croce eretta di fronte al cippo che ricordava i caduti della grande guerra , di camiciole troppo eleganti che ostacolavano ogni mio gesto e di quelle maledette scarpette lucide e strette che attanagliavano in una ferrea ed implacabile morsa alluce e mignolo non consentendogli il minimo movimento. Quei sottili cravattini che parevano strangolarmi poi!
Per fortuna dopo la Funzione e la processione che seguiva poco dopo, si tornava al caro e consueto abbigliamento, laceri calzoncini scuri, una pratica e confortevole maglietta a righe e calzettoni con elastico largo rigorosamente calati su un paio di comode scarpe da ginnastica già sufficientemente rovinate da non dover temere ulteriori danni nella probabile evenienza di incontri ravvicinati con palloni ,pietre e radici sporgenti.
All’approssimarsi nella stagione venatoria,incredibile a dirsi,mi capitava talvolta di andare a caccia con zio Elmo, dinamico predatore clone di Jhon Wayne, e mio cugino Sandro, gli animali tuttavia li preferivo vivi,a meno che si trattasse di monumentali bistecche ben cotte e guarnite di patatine fritte.
Era suggestivo alzarsi all’alba,camminare per ore per quelle sconfinate spianate verdi, respirare l’aria effervescente del mattino scotendo la rugiada che si raccoglieva sugli scarponi.
Un tardo pomeriggio poi il cacciatore tornò dal bosco stringendo tra le mani le lunghe orecchie della sua preda che si dimenava spaventata,una piccola lepre moribonda che grondava sangue .
Quegli occhi tristi mi fissavano e sembravano implorarmi,la impalò ancora viva di fronte casa sotto il pergolato della bottega e cominciò a scuoiarla.
Presenziai a quella cruenta scena con raccapriccio senza riuscire a parlare, la poveretta agonizzava appesa ai ganci dibattendosi disperata mentre il sangue colava copioso dalle ferite inferte dal carnefice,lasciando intravedere le viscere. Seguivo inebetito l’agghiacciante spettacolo quando un misericordioso ultimo violento fendente le recise la gola ,lo sfortunato animale con un ultimo sussulto reclinò la testolina che cadde ciondoloni da un lato e smise finalmente di soffrire.
Tornai a casa profondamente avvilito , da quel momento decisi di abbandonare per sempre quel sanguinario passatempo,né l’aria pungente del primo mattino,né le rinfrancanti scarpinate sul far del giorno potevano valere la vita di quelle innocenti bestiole.
Un evento atteso da tutti i bambini del paese era poi l’arrivo della trebbiatrice, una gigantesca macchina con lunghi nastri trasportatori che veniva assemblata nel campo di Edda nei pressi del bivio.
Era un autentico spasso per tutti noi tuffarci in quei covoni di spighe ricoperte d’oro , giocando a nascondino tra le balle di fieno correvamo allegramente tutto il giorno per poi sdraiarci esausti tra la trebbiatura dorata al riparo di quel sole bruciante ,approfittando dell’ ombreggiata frescura dei fasci di spighe mature.
Quanti ricordi ancora tornano alla mente!
Confusi, indefiniti,vorrebbero fendere Il velo della memoria ma vengono inghiottiti dal gorgo del tempo poi sembrano affacciarsi più chiari, ne traccio i contorni,vorrei lasciarli riposare, ma non c’è niente da fare s’intrufolano prepotenti nel turbinio dei flashback e schizzano fuori in bianco e nero come spiritelli fastidiosi.
Come posso non accennare,ad esempio,alla carriola rossa?
Accadde un mattino sempre nel paese di Alice ,subito dopo colazione avvertii delle fitte lancinanti ad un dente, la mamma, preoccupata, dopo aver atteso invano un’attenuazione del dolore si convinse che l’unico rimedio sarebbe stato quello di accompagnarmi con la corriera a Tagliacozzo - papà si trovava a Roma per lavoro - per farmi visitare da un dentista.
Giunti a destinazione un anonimo cavadenti - il primo e l’ultimo, per fortuna, che incontrai lungo la strada nei miei primi quarant’anni - non perse tempo nell’ estrarmi il dente malato.
Tornati in strada ci dirigemmo verso la fermata della corriera ma sulla via del ritorno c’imbattemmo nelle chiassose bancarelle di una fiera. Mentre premevo con un fazzoletto sulla guancia arrossata i miei occhi intercettarono una sfavillante carriola rossa di plastica che luccicava al sole appoggiata ad un carretto ,mamma, come volesse compensarmi per l’immatura e improvvisa perdita del molare,decise di comprarmela.
Il giorno dopo con il mio nuovo giocattolo trasportavo allegramente mucchi di terriccio e ciottoli dal piazzale di cemento verso il gazebo collocato nell’orticello di fronte casa, quando trovai adagiato nell’erba un passerotto morto,lo sollevai e lo collocai nella carriola accompagnandolo alla sua ultima dimora,scavai una piccola fossa dove lo deposi e dopo aver di nuovo riempito di terra la buca ci piantai sopra due zeppetti di legno a forma di croce.
Rimasi profondamente rattristato da quel primo incontro con la morte ma soprattutto mi ferii l’incomprensibile rimprovero dei miei genitori per aver concesso una sepoltura cristiana a quell’uccellino, a lungo tentai di comprenderne il motivo ed anche quando ,qualche anno dopo, pazienti catechisti tentarono d’insegnarmi i primi fondamenti di carità cristiana non rimasi convinto dalle loro argomentazioni.
Il fascino seducente di quel paese smarrito tra i monti prese a condurmi inevitabilmente lungo la rotta dei sogni.
Durante quelle tiepide estati, ormai lontane ,appoggiato alla ringhiera della veranda ascoltavo gli interminabili silenzi delle notti gravide di astri splendenti ricamati sull’infinita tela di quel cielo nero, pian piano cominciai a riconoscere le costellazioni del grande e del piccolo carro, a seguire con il dito la linea argentea della via Lattea e a desiderare la Luna osservando stregato le sue lunghe e fragili ombre cercando nell’oscurità delle tenebre l’incantesimo delle stelle cadenti che sparivano all’orizzonte inghiottite dal contorno dei monti. Con la complicità di quelle notti stellate avvertii i primi morsi dell’amore e l’impercettibile amarezza dell’inevitabile malinconia che l’avrebbe tallonato.
Di lì a poco il primo incontro con questo strano sentimento.
Un caldo pomeriggio salivo lungo la mulattiera che conduce alla Cona insieme ad una ragazzina bionda quando improvvisamente cominciai ad avvertire un insolito nodo alla gola che pareva soffocarmi accompagnato da insistiti morsi allo stomaco che non mi davano tregua . In principio pensai si trattasse di fame ma fui prontamente smentito da una singolare sensazione di piacevole trepidazione mista alla preoccupante intuizione di una sgradevole inquietudine . Mi fermai a pensare poi compresi e impallidii ,non c’era il minimo dubbio,me ne avevano parlato gli amici che c’erano passati prima di me , si trattava degli inconfondibili sintomi di un’ irrimediabile cotta!
Ad un tratto m’accorsi che alla mia rupestre amichetta s’era slacciata la camicetta e s’era affacciato, malizioso uno spicchio di reggiseno - me ne avevano parlato di questo strano indumento intimo femminile ma non avevo mai avuto il piacere, fino a quel momento, d’approfondire tale conoscenza. Percepii uno strano fremito che mi fece rabbrividire e capire che la frittata era fatta.
Tiziana, questo era il suo nome, resasi conto del mio turbamento si ricompose immediatamente ma non abbastanza,avevo ormai scoperto l’allarmante significato della parola amore e, quel che è peggio ,lo stuzzicante turbamento delle sensazioni provocate da quello che gli amici più grandi chiamavano sesso.
Non ci fu altro ma la malizia di quell’ istante segnò indelebilmente il mio definitivo passaggio all’età adulta,quel fazzoletto di seno che aveva fatto capolino dal reggipetto rosa colorò a tinte più aggressive i giorni che seguirono chiudendo definitivamente i pastelli delicati della fanciullezza nell’astuccio dei ricordi.
Porca vacca! Si torna a quando ero bambino.
Abbiate pazienza ma lo scombinato treno dei ricordi ha di nuovo invertito la marcia e retrocede di qualche fermata per raccogliere quei frammenti di memoria rimasti indietro.
Torniamo dunque a questa ironica e disincantata storia di vita.


